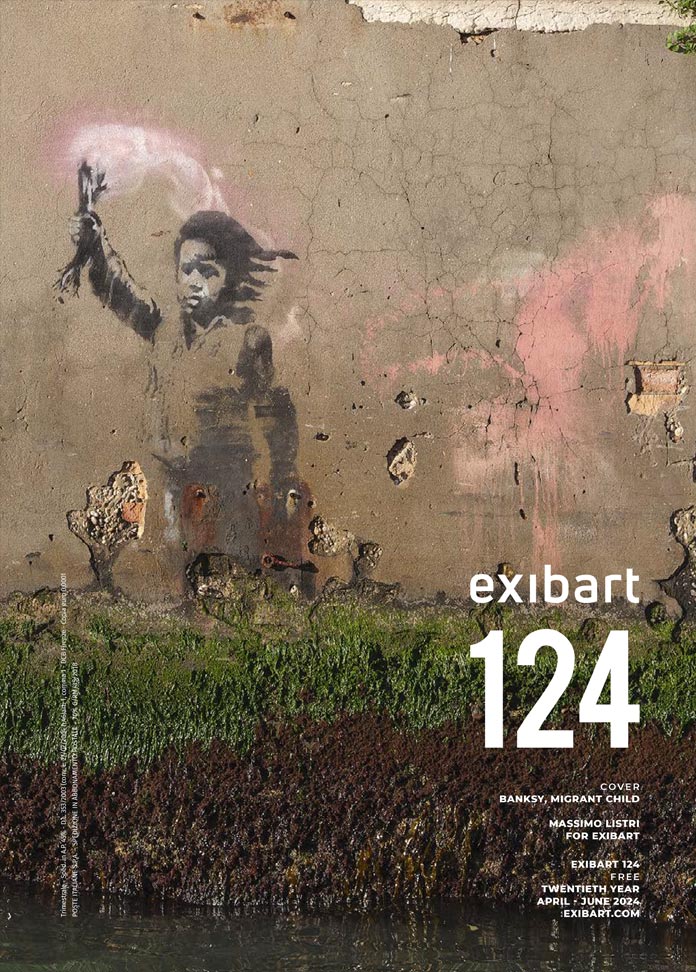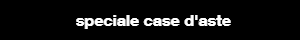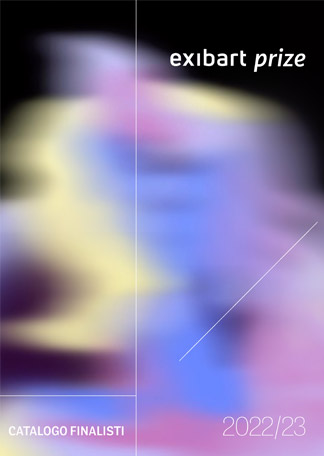Create an account
Welcome! Register for an account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
-
- container colonna1
- Categorie
- #iorestoacasa
- Agenda
- Archeologia
- Architettura
- Arte antica
- Arte contemporanea
- Arte moderna
- Arti performative
- Attualità
- Bandi e concorsi
- Beni culturali
- Cinema
- Contest
- Danza
- Design
- Diritto
- Eventi
- Fiere e manifestazioni
- Film e serie tv
- Formazione
- Fotografia
- Libri ed editoria
- Mercato
- MIC Ministero della Cultura
- Moda
- Musei
- Musica
- Opening
- Personaggi
- Politica e opinioni
- Street Art
- Teatro
- Viaggi
- Categorie
- container colonna2
- container colonna1
29
marzo 2015
VIAGGIO ALL’INTERNO DELLA MATERIA
Progetti e iniziative
Grazie al restauro promosso da Peggy Guggenheim Collection si entra nel vivo di "Alchemy" di Jackson Pollock. Scoprendo qualcosa di nuovo di un autore celebratissimo
di Irene Guida
Se Peggy Guggenheim, già affermata collezionista e gallerista, è stata coraggiosa a credere nel talento di Jackson Pollock, al momento del loro incontro più che trentacinquenne e poco più che magazziniere di un museo, allora Luciano Pensabene Buemi, il capo conservatore del Guggenheim di Venezia, insieme al curatore Roberto Bellucci, è stato altrettanto coraggioso a sfidare il tempo, la patina e l’immagine consolidata dell’opera più famosa e importante di Pollock e una delle fondamentali della collezione Guggenheim, Alchemy (1947), decidendo di segnare, con questa mostra, una data di rinascita per questo capolavoro.
D’ora in poi dovremo scrivere, in una scheda tecnica dell’opera, Jackson Pollock, Alchemy, (1947-2015), 4.6 kg di materia pittorica, 19 colori. E potremo toccare il suo plastico in 3 D, monomaterico, grigio, prodotto da OCÉ, risultato della modellazione e della scansione micro laser effettuata dal Mo-Lab del CNR, che è servita a costruire il modello 3d virtuale che i sette schermi multitouch nel museo forniti da NEC, più grandi del quadro, che permettono di ingrandire ulteriormente, lasciandoci rivivere il lavoro al microscopio fatto per più di un anno dai restauratori dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, insieme con Il dipartimento di Chimica dell’Università di Torino, in collaborazione con il CNR con il coordinamento del dipartimento di conservazione del Museo Guggenheim.
Prima di questa mostra, infatti, Alchemy era famosa per essere un’opera al nero, appunto, il risultato aggrovigliato di una specie di lotta dell’autore con/contro la materia, la tecnica pittorica e la forma quadro, che consegna il lavoro di Jackson Pollock alla storia dell’arte e lo fa riconoscere al mondo come artista rivoluzionario. L’immagine di Alchemy era di un fondo nero spesso, solcato da alcuni segni come di un alfabeto dimenticato, striato da colori assorbiti in un fondo di lava asciutta e cristallizzata, risaliti a tratti alla superficie, con bagliori argentei, qualche bianco, poche venature di rosso e colori primari visibili a malapena. Questo processo di invecchiamento così rapido è dovuto a quasi sessanta anni di esposizione alla polvere, oltre che all’effetto degli acidi grassi contenuti nelle resine industriali, usate da Jackson Pollock come leganti al posto degli oli per dipinti, che hanno favorito l’assorbimento delle particelle esterne da parte dei pigmenti blu, bianco di zinco, verde che erano i più compromessi. Il pregiudizio romantico era quello di un artista che quasi danza, fa colare colore, e realizza con grande velocità un gesto perfetto, univoco, realizzando un’opera d’arte come negativo impresso dei propri movimenti, quasi un Rayograf materico, istantaneo come una Polaroid.
I risultati dell’applicazione di un metodo che è più che indiziario, da simulazione in quattro D della scena del delitto, ci mostrano una storia e un modus operandi completamente differente: Pollock dipingeva con il tempo e non contro di esso; era consapevole di lavorare al limite fra intenzione e mancanza di essa, in un equilibrio precario e dipendente solo dalla sua attitudine, per questo i quadri richiedevano molto tempo. Inoltre lavorava, proprio per il peso dei materiali che utilizzava, e proprio per concedersi la massima durata nell’esecuzione del quadro, a pavimento ma soprattutto come uno scultore, considerando fasi di cristallizzazione, asciugatura, strutturando il dipinto nella sua architettura di pesi e misure, strati e bassorilievi, lavorando non solo per pura aggiunta, ma anche per abrasioni, limature, incollando pezzi di materiali, objets trouvé, che però si integrassero sempre in forma di dipinto. Come se più volesse negare la natura pittorica del suo lavoro, e più il suo lavoro gli restituisse la forma dipinto. Questo conferma la forza dell’opera di Pollock.
Nessuno storico dell’arte riesce a comprenderlo tanto che per capire finalmente che non è un espressionista astratto, dobbiamo scansionare il suo lavoro, guardarlo per mesi al microscopio, dissezionarlo e ricomporlo. Il paradosso che ci rivela questa mostra dentro un quadro solo, coraggiosa e a tratti inquietante, è che le opere d’arte contemporanee sono degli oggetti che necessitano di interventi di conservazione ancora più forti di quanto non succeda di solito con le opere antiche, perché spesso le opere contemporanee sono realizzate con materiali deperibili, fatti per durare al massimo venti o cinquanta anni, e che noi, i fruitori, i collezionisti, i turisti, i conservatori di musei, gli enti del turismo culturale, affetti da un voyeurismo incurabile, vogliamo durino in eterno; che forse sono state pensate per deperire e superare di poco la vita dell’artista ci disturba. Magari potrebbero rimanere come foto, video, film. In definitiva, proprio come accade al restauro di pellicole nel cinema, o di video-arte, il paradosso dell’arte contemporanea di staccare l’arte e le intenzioni dell’artista del proprio supporto si rivelano un problema che spinge a una serie indefinita di azioni tecnologiche per costruire intorno al lavoro artistico una specie di Frankenstein tecnologico che con la forza di viti e bulloni ne sostenga la fragilità del supporto materiale.
“Alchimia” non è solo un viaggio nella materia, è anche un punto di partenza, se si vuole, per una riflessione sul senso di conservazione per opere il cui contenuto diventa sempre più immateriale, sempre più contestuale, sempre meno legato a un supporto.
Il forte rischio è che d’ora in poi e nonostante questa mostra, nonostante la comprensione profonda che ci regala, il risultato di tutta questa profondità sia l’arte al chilo: il quadro di Pollock, se mai sia stato un quadro, sarà conservato in una teca, brillante della sua palette di 19 colori, mantenuto come il cenacolo di Leonardo, la Cappella degli Scrovegni, la Cappella Sistina, i siti Speciali e le Zone protette, in uno stato di conservazione da sorvegliato speciale in isolamento, perché non ci si dimentichi mai della forza espressiva, della vitalità gestuale, della grande perizia tecnica del pittore che sapeva ben eseguire il dripping, ondeggiare il polso, muoversi come un animale dall’istinto perfetto, danzare sul quadro, e infine, oltre a sporcare il pavimento, staccarne un pezzo e dipingere un quadro. E che questa tecnica si chiama dripping e la possiamo imparare anche noi. Quando l’attitudine diventa monumento siamo spiazzati, non è piacevole accorgersi che abbiamo bisogno dell’eternità o quasi dei supporti, della loro eterna riproducibilità visto che siamo estranei alla sua unica durata reale, che vogliamo conservarli nonostante siano stati pensati per non lasciare tracce se non a breve, per accettare il passare del tempo, incrostandosi, e a questo coraggio della vitalità e della provvisorietà devono la loro grandezza. A Venezia qualcosa di simile è già successo con la mostra curata da Germano Celant alla Fondazione Prada nel 2013, “When Attitudes Become Form”. La riproposizione della mostra di arte concettuale e performativa più importante degli anni sessanta (1969) a Berna, riproposta a Venezia; curatori, committenti, contesto, occasione, tempo, erano tutti diversi. Le opere identiche. La sensazione era di un incredibile ode alla morte, funebre per paradosso. Sarebbe da chiedersi quanto gli artisti ne fossero consapevoli, cosa pensassero al proposito.






.jpg)