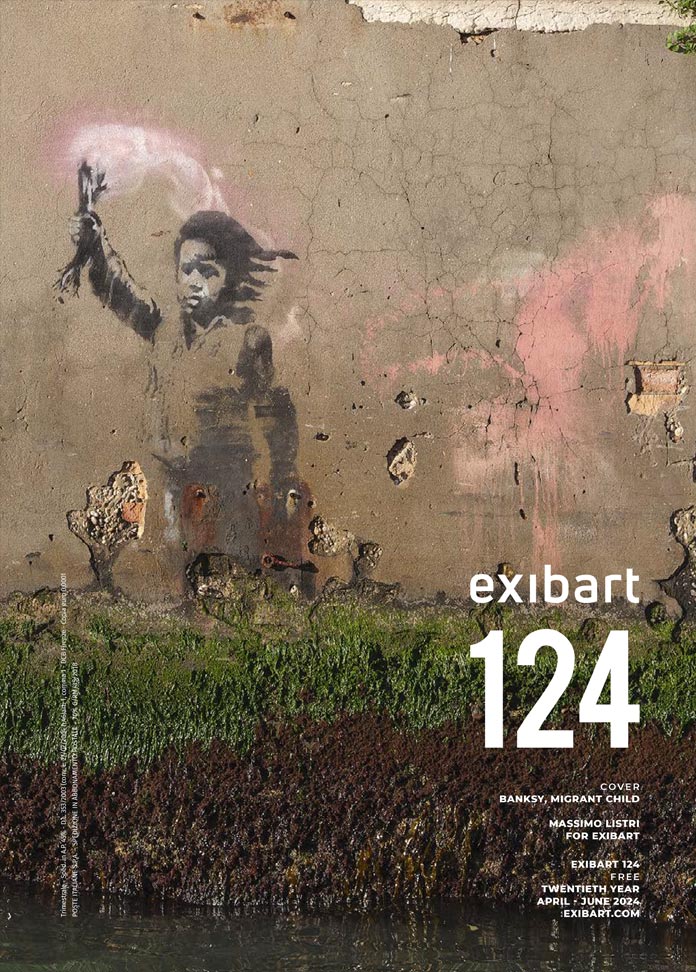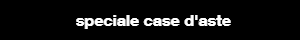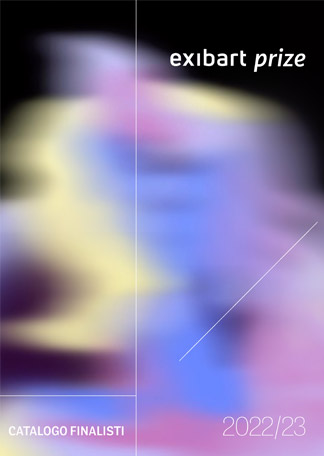-
- container colonna1
- Categorie
- #iorestoacasa
- Agenda
- Archeologia
- Architettura
- Arte antica
- Arte contemporanea
- Arte moderna
- Arti performative
- Attualità
- Bandi e concorsi
- Beni culturali
- Cinema
- Contest
- Danza
- Design
- Diritto
- Eventi
- Fiere e manifestazioni
- Film e serie tv
- Formazione
- Fotografia
- Libri ed editoria
- Mercato
- MIC Ministero della Cultura
- Moda
- Musei
- Musica
- Opening
- Personaggi
- Politica e opinioni
- Street Art
- Teatro
- Viaggi
- Categorie
- container colonna2
- container colonna1
Nell’Ex Carcere Filangieri le piante selvatiche hanno radici resistenti
Extra pART
Nell’angusta stanza quadrata c’è
una sola finestra, la luce la attraversa per traiettorie oblique, sezionando lo
spazio in categorie d’oscurità. Marco e io ci muoviamo con cautela, facendo
attenzione a non calpestare calcinacci e resti di vario genere che, sparsi sul
pavimento come ideogrammi, comunicano nel linguaggio sconosciuto degli oggetti
che si spostano. La veloce grafia da professione medica si distende sulle
campiture porose che la polvere e l’umidità hanno lasciato sui fogli protocollati
e sulle cartelle timbrate. Le parole sono calibrate in formule professionali e
burocratiche, frasi cariche di studi ed etimologie che autorizzano permessi di
visita e certificano condizioni di salute. Sul retro delle fotografie di madri
e padri e di donne in pose lascive, tra le pieghe di bigliettini stropicciati e
passati per varie mani, la grammatica è sospesa nell’espressione soggettiva,
saluti ai genitori, promesse di fedeltà, poesie sconce, sfottò tra ragazzi non
ancora maggiorenni che condividevano lo stesso edificio e una pena simile. Le
sintassi del potere e dell’individuo si alternano, diagnosi e oscenità, controllo
e dispersione istituiscono i propri movimenti grafici contrapposti, sui ripiani
dell’alto archivio di ferro che Federica
Romano ha allestito in una delle centinaia di celle dell’ex Istituto di
Rieducazione Filangieri, per il progetto Le
Malerbe, «una ricerca etnografica dello spazio dell’abbandono».

Per anni, le porte dell’ex
Istituto di Rieducazione Filangieri sono state chiuse ma, dal 2015, la rete di
collettivi Scacco Matto sta lavorando duramente per recuperare l’edificio che si
sviluppa su un’area molto vasta, un’immensa isola fluttuante nei vicoli del
quartiere Montesanto. L’ex centro di rieducazione fu istituito nel complesso
abbaziale di San Francesco delle Cappuccinelle, eretto nel XVI Secolo per
volere di una nobildonna vedova e gestito da suore dell’ordine francescano, in
favore delle ragazze madri. A metà Settecento, il grande complesso fu completamente
rifatto e aggiornato ai modi del tardo barocco, con stucchi e marmi, trompe
l’oeil e festoni con temi floreali che, oggi, sono ricoperti da una fitta
epidermide verdeggiante, risultato di copiose infiltrazioni d’acqua. Nel 1809 Gioacchino
Murat ordinò la soppressione del monastero e la sua conversione in riformatorio
minorile, che prese il nome dal giuslavorista Gaetano Filangieri, orientandone
la funzione circondariale, rimasta sostanzialmente immutata fino ai giorni
nostri, in particolare nella memoria collettiva. Il progressivo
ridimensionamento si è protratto fino al 2000, quando l’intero complesso, di
proprietà demaniale, fu acquistato dall’Università Parthenope. I lavori di
ammodernamento non partirono mai e la struttura, rientrata nella proprietà del
Comune, fu abbandonata a se stessa, fino all’anno scorso. Oggi si chiama
Scugnizzo Liberato e ogni settimana si svolgono attività eterogenee, da corsi
di lingua araba e ceramica, a sportelli di assistenza per i migranti e
laboratori teatrali e performativi. Fino alle mattinate di lavori e pulizie,
aperte a chiunque voglia dare una mano, perché gli spazi dello Scugnizzo sono
enormi e renderli liberamente fruibili è l’obiettivo dichiarato.

Usciamo dalla stanza
dell’archivio e ci incamminiamo per il corridoio che affaccia sull’ampio cortile
interno, completamente circondato da finestre che si sovrappongono,
moltiplicando l’identica partizione dello spazio tra infiniti punti di
osservazione. Intrecci di rampicanti affollano il condotto esterno
dell’ascensore, le piante selvatiche, rigogliosamente innestate sui materiali
da costruzione, ricoprono le facciate, costituendo una scenografia ibrida di
legno e cemento, clorofilla e calce. Questo paesaggio si ripete ogni giorno
uguale a se stesso, fatta eccezione per una infinitesima percentuale di
cambiamento che sta continuando a creare un nuovo habitat. Potremmo essere gli
ultimi o primi al mondo a vedere questa celebrazione in cui i concetti di
relatività del tempo si sovrappongono, le stagioni metereologiche e
astronomiche che condizionano il ciclo della fioritura, echi di passi sempre
più fiochi, simili a vapori, in quel che rimane dei corridoi e delle scale, foglie
ingiallite e bottiglie di plastica ugualmente percorse dagli insetti e dalla
polvere, usate come rifugio dalle spore. Periodi di silenzio o di frequenze non
udibili scivolano sulle crepe dell’intonaco e sulle nervature delle foglie,
unendo l’architettura umana e vegetale in un microcosmo di relazione. Tale punto
di coincidenza tra le identità resistenti delle piante selvatiche e dei reclusi
è il nucleo intorno al quale Federica Romano ha impostato la riflessione de Le Malerbe: «Le erbacce sono
considerate malerbe, perché infestanti e vanno eliminate; i detenuti sono
associati allo stesso appellativo, perché ritenuti socialmente pericolosi e
rinchiusi in luoghi destinati all’isolamento dalla società». L’installazione è
diffusa tra gli ambienti, foglie, rami, radici, documenti privati, certificati,
fotografie, sono sovrapposti e disseminati lungo un cammino di immersione nella
storia. Oltrepassiamo una distesa di fronde accatastata sul pavimento ed entriamo
in una cappella barocca.

Qui, gli ornamenti ricchi e
screpolati generano un intenso ritmo di chiaroscuri, un dilatato sottofondo
visivo al movimento di due piante selvatiche fatte d’ombra, scarni vortici
oscuri tendenti verso l’unica fonte di luce. Migliaia di storie si animano,
dottori in camice bianco scrivono le loro diagnosi, ragazzi parlano in dialetto
dell’ultima partita, addetti alla manutenzione innaffiano vasi di gerani, come se
infiniti altri mondi continuassero tenacemente a esistere, pochi centimetri al
di qua del nostro, per qualche istante nella nostra immaginazione.






.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)