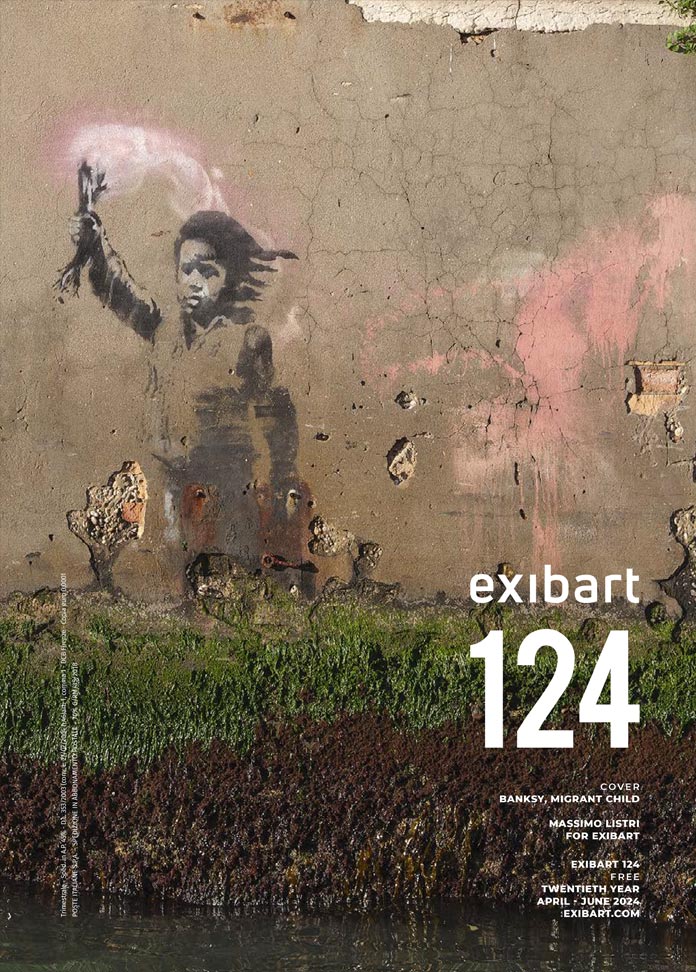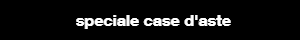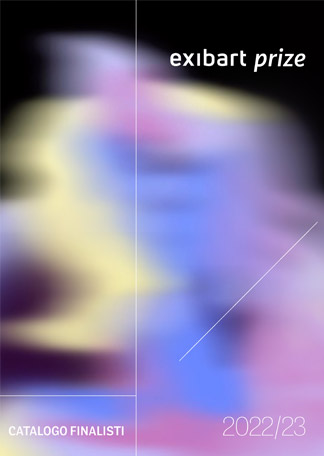Create an account
Welcome! Register for an account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
-
- container colonna1
- Categorie
- #iorestoacasa
- Agenda
- Archeologia
- Architettura
- Arte antica
- Arte contemporanea
- Arte moderna
- Arti performative
- Attualità
- Bandi e concorsi
- Beni culturali
- Cinema
- Contest
- Danza
- Design
- Diritto
- Eventi
- Fiere e manifestazioni
- Film e serie tv
- Formazione
- Fotografia
- Libri ed editoria
- Mercato
- MIC Ministero della Cultura
- Moda
- Musei
- Musica
- Opening
- Personaggi
- Politica e opinioni
- Street Art
- Teatro
- Viaggi
- Categorie
- container colonna2
- container colonna1
15
settembre 2016
L’osservatorio umano made in New York
Progetti e iniziative
Tra le mostre della Grande Mela da non perdere c'è quella del Whitney. Una carrellata di sguardi a raccontare (quasi) tutta l'anima e la storia. Dell'America, e nostra
A poco più di un anno dall’apertura a Meatpacking, e dopo la grande “America is hard to see”, il Whitney Museum torna a colpire nel segno (e meno male) con una mostra che raccoglie il meglio della sua collezione, declinata però su un tema molto preciso: il ritratto e l’autoritratto, nelle sue più svariate forme, attraverso il Novecento e fino ai giorni nostri, con due grandi assi a reggere la mostra: da un lato quella che viene definita la “frattura dello specchio”, ovvero la sezione al settimo piano del museo di Renzo Piano, che in questo caso raccoglie la parte storica, legata alla rottura che gli artisti ebbero con il figurativo all’indomani della seconda guerra mondiale, quando in Europa pulsava forte l’Informale, con i suoi grumi, tagli e liquefazioni, e dall’altra parte dell’Atlantico l’Espressionismo Astratto e il Colour Field.
Al sesto piano, invece, è lo specchio di Andy Warhol che ci conduce alla maniera contemporanea di vederci e, contestualmente, di ritrarre l’altro.
Non è una mostra gigante “Human Interest. Portraits from the Whitney’s Collection” (fino al 12 febbraio 2017), ma è una messa in scena che traccia, con alcune parti essenziali, un tema che è sempre stato molto caro alla storia dell’arte; quello dell’esplorazione dell’umano, appunto, nel volto e nell’anima.
Ad aprire idealmente la mostra è il ritratto di Gertrude Vanderbilt Whitney di Robert Henri, del 1916, che racconta bene l’opulenza della giovane americana che si fece pigmalione per i moderni artisti dell’epoca, e la cui storia è nota: nel 1914, in una delle molte proprietà che i coniugi Vandebild-Whitney possedevano a Manhattan, Gertrude istituì il Whitney Studio Club (all’8 della West 8th Street al Greenwich), dove i giovani potevano esporre le loro opere. Il luogo, nel tempo, sarebbe poi divenuto l’attuale Whitney Museum of American Art, fondato nel 1931 a seguito del rifiuto da parte del Metropolitan di accogliere la donazione di Mrs. Whitney di quella che, nel frattempo, era diventata una raccolta venticinquennale di opere di arte moderna. Et voilà.
C’è molta New York, in effetti, in questa mostra; il Whitney, come è noto, non può prescindere dalla necessità di omaggiare le sue origini, e anche i New Yorker di Howard Kanovitz, fanno parte del clima degli anni ruggenti della Grande Mela. Il dipinto racconta nel pieno della Pop Art – la pittura e ricavata dalla fotografia di un giornale – dell’entourage di Mr. Richard Rodgers, ovvero il creatore dei colossal di Broadway. Uno spaccato dei ’60’s, e una delle facce della Big City, in questo caso quella di Midtown.
Ma in scena ci sono anche gli altri volti di New York, i ragazzi del ghetto per esempio, le donne e gli artisti, anche se sono quasi completamente assenti quelle voci che hanno lavorato su questioni più scomode come l’apartheid, per esempio.
Incontriamo poi le fotografie di Jamel Shabazz, nato nel 1960 a Brooklyn e che appena 20enne scatta alla sua tribù di coetanei immagini che (stampate nel 2001) appaiono oggi come modernissime.
Sarà forse che l’azione del ritrarre e ritrarsi è in qualche modo iscritta in maniera quasi animale e istintiva nella nostra voglia di conoscenza.
Tradizionale o meno, in questa prima sezione tra le quadrerie e alcuni miti che non potevano mancare come Hopper sia nel suo più celebre autoritratto (1925-30) che nel mitico dipinto A woman in the sun, dove la moglie Josephine Nivison, all’epoca 78enne (siamo nel 1961) posa nuda, immersa nel sole, in una scenografia completamente metafisica, c’è anche una sezione dedicata ai ritratti senza umani. Ed ecco che salta fuori un altro cavallo di battaglia del Whitney: Jasper Johns con Racing Thoughts del 1983. Immerso nella sua vasca da bagno, dell’artista si vedono solo i suoi riferimenti: un paio di pantaloni caki appesi, e una riproduzione della Monna Lisa, un ritratto del gallerista Leo Castelli, le ceramiche di George Ohr, una litografia di Barnett Newman alle pareti: è la fotografia di un momento in cui la mente si abbandona, i pensieri a fluire oniricamente, e allo stesso tempo il quadro diviene il set in cui si scopre la cultura dell’artista, quel substrato che ha permesso lo sviluppo di poetiche e opere: il dietro le quinte. Come un ritratto, appunto.
E se per la “questione modella” forse bisognerebbe spendere qualche pensiero psicanalitico nei confronti di Hopper e del suo rapporto con Josephine, benvenuti al secondo piano, dove la situazione si fa più complessa, e subentrano non solo i ritratti agli amici, vedi Urs Fisher che crea una sorta di monumento a Julian Schnabel, spropositato e demiurgico, ma nell’interesse umano il corpo assume la dimensione politica.
E allora c’è Glenn Ligon con la questione dei documenti e della razza, ci sono i pugni alzati della protesta, di Martin Luther King Jr. e Richard Nixon, ma anche quelli di Woodstock e quelli di Jane Fonda messi in scena completamente decontestualizzati, da Annette Lemieux, a ricordaci che Left Right Letf Right, senza una storia intorno, è un gesto universale di rabbia, protesta, solidarietà o semplice “vittoria” intercambiabile.
E poi c’è Mike Kelley con un vastissimo Educational Complex, a ricordarci come la formazione sia agli albori della vita il modo migliore per creare o deformare il nostro ritratto sociale, mentre la texture cromatica di Byron Kim, olio e cera su legno, mappa come una cartografia monocroma proprio il colore di 40 illustri colleghi, da Janine Antoni, Kiki Smith, Chuck Close e Donald Moffet, presenti nella collezione del museo. E a cosa siamo di fronte, se non a un ritratto – anche – del sistema dell’arte americano?
Sul finale, tema ormai sdoganato, c’è il dramma della complessità dell’affermazione del proprio genere, in una sezione dedicata al “Body Bared” dove troneggia Alice Neel con il ritratto di Andy Warhol nella probabilmente unica versione dell’artista a torso nudo. Sul suo busto un infinito circolo di cicatrici, che raccontano del suo tentato omicidio da parte di Valerie Solanas, nel 1968, due anni prima del dipinto; un episodio che non solo segnerà per sempre l’artista, ma che racconta anche di un altro corpo; quello della celebrità e della difficoltà di portarsela addosso.
Sul limitare di questa sezione sta Rudolf Stingel, con il suo ritratto Apres Sam, ovvero come l’artista è stato immortalato dall’amico Sam Sarone in un momento di pausa nel letto di un albergo. Sdraiato nella penombra, l’artista che ha definito il dipinto non un autoritratto ma «un quadro dove ho dipinto una fotografia di me», sembra accarezzare non solo un pensiero, ma anche un’alta dose di melanconia, una solitudine strisciante.
Non mancano poi i momenti ironici, quasi sguaiati. Al centro del settimo piano, se indugerete un po’, sentirete Madonna cantare Vogue. Viene da uno degli irriverenti video di Charles Atlas, nativo del Missouri, intitolato proprio Butcher’s Vogue, dove due scatenate Madonnare, simili quasi più a transessuali, si dimenano in un bar fino all’adescamento di un poveretto che, una volta portato nel basement con la promessa di una sveltina, viene malmenato. Fino all’arrivo del poliziotto che punta la pistola, chiudendo la performance.
Ma il corpo nudo, e anche quello sessualizzato, si ritrova anche nel ritratto del performer Ron Athey e dei suoi tatuaggi, simboli di una vita, scattato negli anni ’90 da Catherine Opie, nei volti scavati di Mark Morrisroe e al “selfie” del 2003 di Jack Pierson, all’epoca 33enne e vicino a una sorta di estetica queer patinata, fatta di ragazzi acqua e sapone, e bianchi. A dir la verità ben poco diversi da quella Woman with dog di Duane Hanson (1977) intenta a leggere una lettera, scritta chissà da chi e da dove. Mentre lei è invece lì, negli abiti di una vita indossata quasi senza convinzione, nella serafica e mortifera pacatezza di un interno domestico che non vediamo, così quelli di una notte dove ci perdiamo, vista negli occhi di molti da queste parti. Anche questo è “Human”, e non post. Per fortuna.
Matteo Bergamini
















.jpg)