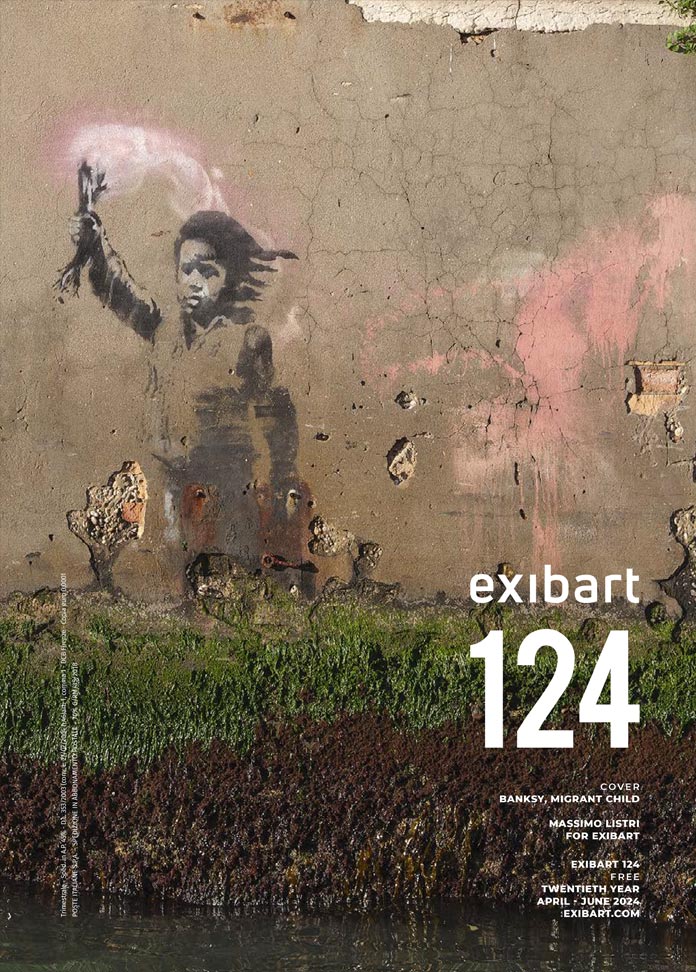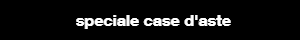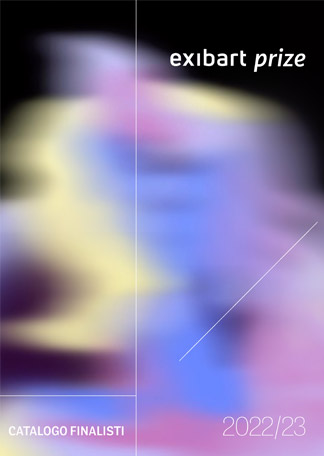Create an account
Welcome! Register for an account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
-
- container colonna1
- Categorie
- #iorestoacasa
- Agenda
- Archeologia
- Architettura
- Arte antica
- Arte contemporanea
- Arte moderna
- Arti performative
- Attualità
- Bandi e concorsi
- Beni culturali
- Cinema
- Contest
- Danza
- Design
- Diritto
- Eventi
- Fiere e manifestazioni
- Film e serie tv
- Formazione
- Fotografia
- Libri ed editoria
- Mercato
- MIC Ministero della Cultura
- Moda
- Musei
- Musica
- Opening
- Personaggi
- Politica e opinioni
- Street Art
- Teatro
- Viaggi
- Categorie
- container colonna2
- container colonna1
25
ottobre 2016
La fine di un mondo tra bagliori di futuro
Progetti e iniziative
Raccontare il tempo che ci appartiene con le parole dell’arte. Nella lucida consapevolezza che segna la vanità delle nostre azioni. Questo ed altro al nuovo Pecci di Prato
di Paola Tognon
Il nuovo Centro Pecci di Prato si presenta alla sua riapertura – dopo sei anni di lavori e tre anni di chiusura per l’ampliamento di Maurice Nio sull’edificio originario di Italo Gambarini – con un grande progetto di ristrutturazione e ampliamento per un totale di 12.125 metri quadrati di superficie pronti – o quasi – ad accogliere 3110 metri espositivi, un auditorium, una sala polivalente, una biblioteca specializzata (già di 5mila volumi), l’archivio Mario Mariotti, il fondo Leonardo Savioli e le attività riorganizzate in 3 dipartimenti, quello per le mostre e la collezione – oggi composta da 1145 opere di artisti italiani e stranieri; quello della ricerca, editoria e progetti speciali e infine quello dedicato all’educazione. E finalmente il 16 ottobre il Centro Pecci si è aperto alla stampa e al pubblico con un impegnativo progetto espositivo a firma di Fabio Cavallucci, direttore chiamato nel 2014 per traghettare a nuova vita uno dei primi centri d’arte contemporanea in Italia.
“La fine del mondo” (fino al 19 marzo, catalogo Silvana Editoriale), questo il titolo scelto da Cavallucci per la mostra inaugurale, è un’esposizione che spinge la riflessione critica intorno alle cose del mondo osservate dal punto di vista dell’arte e si basa sulla percezione diffusa di inattualità e inadeguatezza che pervade le nostre azioni e il nostro tempo. Nella struttura si presenta come una grande mostra, quasi da manifestazione internazionale, costruita su un complesso impianto curatoriale poggiato sulla scelta di artisti e poetiche prima che di opere, su intrecci multidisciplinari, sul mescolamento tra manufatti e su un andamento filmico per capitoli non cronologici.
Negli esiti il progetto espositivo, composto dalle opere di oltre sessanta artisti internazionali, si visita con un percorso circolare che disorienta e delocalizza il visitatore concentrandone l’attenzione sui lavori che sono proposti secondo un andamento di compressione e dilatazione che sottolinea la distinta intenzionalità delle opere e compone la visione filmica per capitoli atemporali. Come in un tunnel di cui non si conosce percorso e direzione, l’attenzione viene abilmente concentrata e sorretta non solo dallo spaesamento a cui è necessario concedersi, ma anche da intervalli tra colpi di scena inaspettati e silenzi inanimati. Egualmente luce e suono si confondono tra pareti bianche o nere, tra attraversamenti fisici e mentali, tra materia e immagini che lasciano, all’inizio e alla fine del percorso, alcuni spazi dilatati.
Si tratta dello spazio abitato da due fra le quattro installazioni di maggior impatto nella mostra, quella iniziale di Thomas Hirschhorn (Break-Throught One e Two, 2016) e quella finale di Robert Kusmirowsky (Quarantine, 2016). La prima, complice anche la sua duplicazione, si propone come rovina posticcia di un evento a noi sconosciuto che ci accoglie franando dal soffitto della nuova struttura per introdurci in uno scenario apocalittico. Una messa in scena che assume un valore metaforico, un caos della materia che è corpo critico del fare e disfare nel tempo. L’ultima, quella di Kusmirowsky, ci riporta invece all’inizio del percorso dentro un ampio spazio dal biancore abbacinante popolato da oggetti e utensili, anch’essi rigorosamente dipinti di bianco, che appartengono alla memoria di vite comuni. Ultimo fra questi oggetti è “l’abito del defunto”, simbolo e manifesto dell’ineluttabile esito della nostra esistenza. Circolarmente il visitatore torna così all’inizio della mostra che condivide con l’opera di Giovanna Amoroso & Istvan Zimmermann (Australopithecines, 2016): la ricostruzione in scala 1:1 della coppia di australopitechi la cui evidente natura di ominidi restituisce, seppure in una fortunata iconografia sentimentale, la recente e fugace misura della nostra presenza nell’universo.
A rafforzare questo senso d’inizio e di fine, di brevità e ineluttabilità, alle installazioni di Hirschhorn segue il grande lavoro di Enrique Olivera (Transcorredor, 2016) un labirinto dentro l’opera stessa che si propone come viaggio esperienziale, dalla caverna alle radici di un albero che ci restituisce alla luce, o meglio, alla terra. Similmente si giunge al biancore di Kusmirowsky attraversando la stupefacente installazione di Cai Guo-Qiang (Head On, 2006): 99 lupi che corrono in branco andando a sbattere con violenza contro una parete di vetro prima di ritornare, con altrettanta ferocia, al punto di partenza. Animali coraggiosi e indomiti la cui energia collettiva può comunque essere manipolata e canalizzata verso l’inutilità o il disastro.
Al centro della mostra un numeroso nucleo di opere, manufatti e materiali che necessitano di un’attenzione paziente e soprattutto flessibile per ricostruire, tra vuoti e pieni, una sorta di colonna vertebrale dell’idea stessa sottesa alla mostra. Tra queste, giocate tra storia e discipline, spiccano per assonanze nella ricerca di un’elencazione infinita, le opera video di Isabelle Cornaro (Figures, 2011) e Camille Henrot (Grosse Fatigue, 2013), ma anche quelle di Polina Kanis (Celebration, 2015) e Taddeus Kantor (Children at their desk from the dead class, 1975-1989).
Nel video della Kanis il ballo sonnambulo e tragico di uomini in divisa che si muovono senza mai guardarsi e guardarci sembra infatti pienamente riattualizzare i manichini di Kantor che sono memoria e morte della sua pratica teatrale. Varco tra installazioni di grande impatto e una somma di opere giocate sull’incertezza e sullo spaesamento vi è l’opera di Gianni Pettena (Complementi di architettura, 1978/2016): un muro a misura umana fatto con ciottoli, pietre spezzate e infine squadrate e levigate. Già realizzata per la Biennale di Venezia del 1978, l’installazione di Pettena acquisisce qui un’altra urgenza simbolica: quella di un muro che da esercizio della tecnica, del sapere e della storia umana, atto a costruire rifugio, diventa sbarramento di disumana natura e di tragica attualità. Proprio quest’opera, con la sua solida concretezza, tra passate civiltà e pressanti attualità, raggiunge con efficacia le ricerche di senso di una mostra che, nell’aprire a nuova vita un’istituzione culturale, affonda nella visione lucida e disillusa di chi, come assunto, osserva e registra la fine di un mondo.
Ma è l’arte, in questo sentimento di finitezza, che viene indicata come una fra le possibili lenti di osservazione di cui opere e posizioni sono possibile presagio, domanda e testimonianza. È in questa logica che l’esposizione “La fine del mondo” si pone come condivisione di un sentire comune, quello di un’epoca che, volgendo al termine, spinge a ripensare al passato umano dentro quello, incommensurabilmente più lungo, del pianeta.
Si può infine ricordare che alla sua apertura la mostra “La fine del Mondo” sembrava ancora un grande cantiere che negava la fruibilità di molte opere, che la complessità del tema a volte sembra muoversi tra la sfrontatezza quasi didascalica di alcuni lavori e l’ermeticità icastica di altri e così via per molte altre considerazioni che, in attesa di analisi, hanno popolato post e relazioni di numerosi internauti. Ma credo che si debba dire che ancora una volta, Fabio Cavallucci è riuscito a costruire – con un progetto fortemente autoriale come spesso nelle sue corde – visioni che stimolano e sollecitano dibattiti e riflessioni, siano essi per assonanza o dissonanza, per condivisione o contrapposizione.
In questa valutazione ritrovare artisti a lui cari e qui richiamati all’opera, stress da cantieri mai finiti, format di allestimento a carattere compulsivo, ma anche trasposizioni e spigolature di visioni caratteriali e personali, legate anche a un indice generazionale ed esperienziale, ci pone convintamente di fronte all’evidenza di una scelta assunta: quella di voler raccontare qualcosa che ci appartiene con le parole dell’arte, nella lucida consapevolezza che segna la vanità delle nostre azioni. E con qualche bagliore di futuro, come spesso succede nei cantieri.
Paola Tognon
In alto: installazione di Cai Guo Quiang
























.jpg)