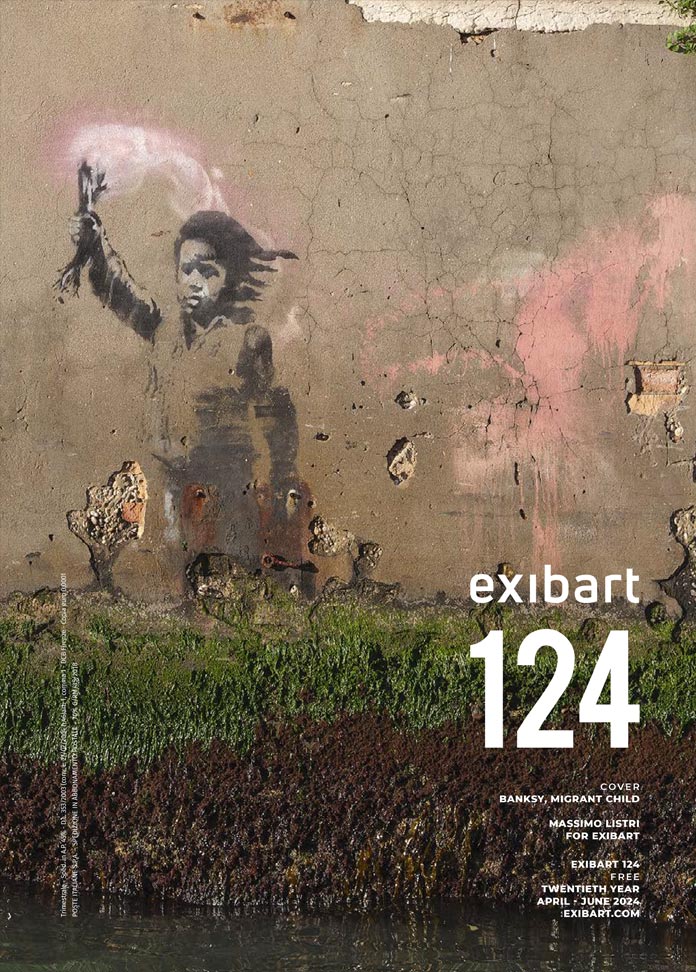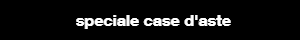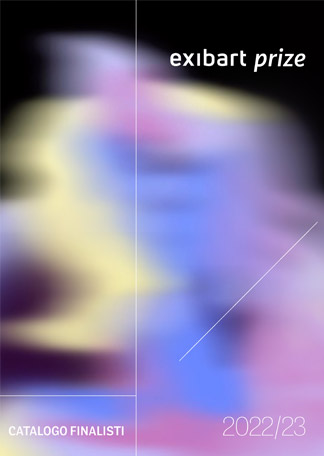Create an account
Welcome! Register for an account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
-
- container colonna1
- Categorie
- #iorestoacasa
- Agenda
- Archeologia
- Architettura
- Arte antica
- Arte contemporanea
- Arte moderna
- Arti performative
- Attualità
- Bandi e concorsi
- Beni culturali
- Cinema
- Contest
- Danza
- Design
- Diritto
- Eventi
- Fiere e manifestazioni
- Film e serie tv
- Formazione
- Fotografia
- Libri ed editoria
- Mercato
- MIC Ministero della Cultura
- Moda
- Musei
- Musica
- Opening
- Personaggi
- Politica e opinioni
- Street Art
- Teatro
- Viaggi
- Categorie
- container colonna2
- container colonna1
20
marzo 2017
Henri Cartier-Bresson, professione fotografo
Progetti e iniziative
Era un ragazzo nervoso, amante della pittura. Poi decise di dedicarsi alla fotografia, per diventare Henri Cartier-Bresson. A Genova 140 scatti ne ripercorrono la storia
Un fotografo deve saper cogliere l’attimo. Questa è la tesi granitica, l’assioma vox populi che ha trasformato il fotografo stesso in un «pistolero, pronto a scattare al momento», come ironicamente dice Denis Curti. E che si autodistruggerà sotto i vostri occhi entro pochissimi secondi.
Perché non era all’America del Far West che aspirava Henri Cartier-Bresson (1908-2004) quando diceva che «fotografare, è riconoscere un fatto nello stesso attimo ed in una frazione di secondo organizzare con rigore le forme percepite visivamente che esprimono questo fatto e lo significano. È mettere sulla stessa linea di mira la mente, lo sguardo e il cuore». Da qui in poi la frittata è stata fatta e rigirata più volte, il travisamento logico de “l’istantanea che più istantanea non si può” ha germinato e nutrito orde di proseliti in cerca dello scatto unico e perfetto. E la mostra Henri Cartier-Bresson – Fotografo, curata proprio da Curti (a Palazzo Ducale fino all’undici giugno), gioca molto su questo errore interpretativo.
Sentir parlare Curti di «attesa», e che «il momento decisivo te lo dovevi cercare» spezzerà il cuore a tutti coloro i quali hanno finora trovato nel grande fotografo francese il loro spara-scatti assoluto. L’aut aut è «o decidiamo che è stato molto fortunato, o che era molto bravo a trovare il momento decisivo», a selezionarlo nel lasso tempo-iconico di «scatti effettuati in successione allo stesso soggetto, e di cui poi ne sceglieva esclusivamente uno» come continua il curatore, citando poi il mitico scrapbook in cui il fotografo parigino raccolse numerose immagini dell’Europa all’epoca della Seconda Guerra Mondiale. Bravura cui il cosiddetto “fattore c” deve necessariamente aver dato una spintarella, altrimenti oggi Curti non potrebbe aprire una parentesi sul come Cartier-Bresson spesse volte fosse «al posto giusto, nel momento giusto e con le persone giuste».

Spirito da documentarista dei suoi tempi, interesse per il reportage come racconto che non cerca l’iconicità assoluta dei suoi singoli scatti. Prima di tutto però il Cartier-Bresson presente a Palazzo Ducale è un giovane incerto sul suo futuro espressivo, attratto dalla pittura, innamoratosi della fotografia e dei primi approcci con la sua Leica, fino a co-fondare l’agenzia Magnum e diventare uno dei nomi più citati nel settore. Un “fotografo”, come con semplice ingenuità sottolinea la mostra, che ha saputo scuotere l’imperturbabilità delle istantanee per farne prevalere il valore narrativo, laddove la precisione tecnica perde sotto i colpi di soggetti sfocati come ancora in pieno movimento. Poeticamente più che esplicativi sono due ritratti all’amico Alberto Giacometti, dapprima mosso, carico di fermento mentre smista le sue opere in preparazione di una personale parigina; poi fermo, buffamente coperto fino alla testa con l’impermeabile, ché senza ombrello la pioggia battente non perdona. Qualche istante prima d’incontrarsi a pranzo con lo stesso Cartier-Bresson.
Narrare per Cartier Bresson era in fondo dare una forma fotografica alla naturalezza con cui infiniti momenti di vita si dipanano nel tempo, una coscienza che fu di fondamentale ispirazione per il nostro Gianni Berengo Gardin. Nel ’61 poteva esserci appunto Giacometti, poco meno di trent’anni prima la domenica di nerboruti lavoratori francesi col loro pic-nic sulle rive della Senna, o l’accoppiamento di due cani con altrettanti simili a fare da voyeur. Situazioni decisamente agli antipodi a cui Cartier-Bresson rispondeva – per giunta a distanza di anni – con un’identica ideologia creativa. E benché l’ultimo degli scatti appena citati non rappresenti nulla da tramandare ai posteri (meno certo dei ritratti ai vari Bonnard, Matisse, Ezra Pound), è nel suo piccolo uno dei più indicativi di una sua certa bravura nel selezionare quel “momento-istante-attimo decisivo” che torna ossessivamente nelle parole di Curti come nei testi d’accompagnamento.
Ma se le 140 immagini presentate non rappresentano un quantitativo smisurato in proporzione alla stazza del personaggio, alla fine – come capita spesso in questo tipo di retrospettive – sono ancora meno quelle che occorrono a focalizzare una cifra identitaria sul piano critico. Non aver scelto poi una linearità cronologica, bensì «tentato d’istituire un percorso geografico, per rendere la mostra più comprensibile», come racconta Curti, restituisce lo strano effetto di trovare tutto il clou compresso all’inizio, in una sezione “Francia 1926-1969” che da sola già ben regge la poetica bressoniana, quasi fosse una mostra a sé. E non solo perché tutte le immagini menzionate fin qui appartengono a quella sezione, comprensiva peraltro dell’immagine guida con l’uomo “sospeso” dietro la stazione Saint-Lazare; o perché Curti tiene banco dicendo che «gli scatti di Carter-Bresson hanno sempre un bordino nero. Non si tratta di un vezzo, ma serviva per impedire agli uffici grafici dei giornali di tagliare la foto. Quando non è presente sono avvenute delle modifiche, e lo scatto dell’uomo dietro la stazione Saint-Lazare non ha quel bordo», evidenziando il pregio della rarità per un fotografo che non amava intervenire sui suoi negativi.
È perché forse di fronte alle sezioni tematiche successive vien voglia di alzare le mani. Qui i fondamentali pezzi di storia della fotografia restano inchiodati alla loro individualità, vittime di un contesto generale nel complesso incoerente, dove la divisione geografica sacrifica il piacere del crescendo in luogo della confusione temporale, poco allettante per un pubblico di fascia ampia come quello di Palazzo Ducale. Tecnicamente lo si definisce “scarso appeal”, che i comuni mortali convertono in una “svogliatezza” ad addentrarsi nell’infilata di ambienti della Loggia degli Abati (già di loro piuttosto angusti e claustrofobici), dove le citazioni autografe e i vari testi sembrano fluttuare sulle pareti a loro volta in maniera vagamente scomposta, più didascalica che didattica. Poi vedersi presentare la mostra come una specie di Bignami, ovvero saltando a piè pari tutte le aree centrali (prerogativa del tempo è l’esser sempre tiranno), alimenta l’impressione d’aver sotto mano degli ottimi ingredienti non ricettati con la necessaria cura.
Ciò detto l’estetica surrealista (nei primi anni Trenta l’amore per la pittura condizionava pesantemente i canoni espressivi bressoniani) di un livornese dal volto precisamente coperto/sostituito da un tendaggio annodato, così come la ruralità sovrastata dalla cementificazione nella periferia romana o la frenesia bambinesca ai piedi del Muro di Berlino sono scatti praticamente autoportanti. Niente male per uno che agli esordi dichiarava «per quanto riguarda la fotografia, non ci capisco nulla».
Andrea Rossetti