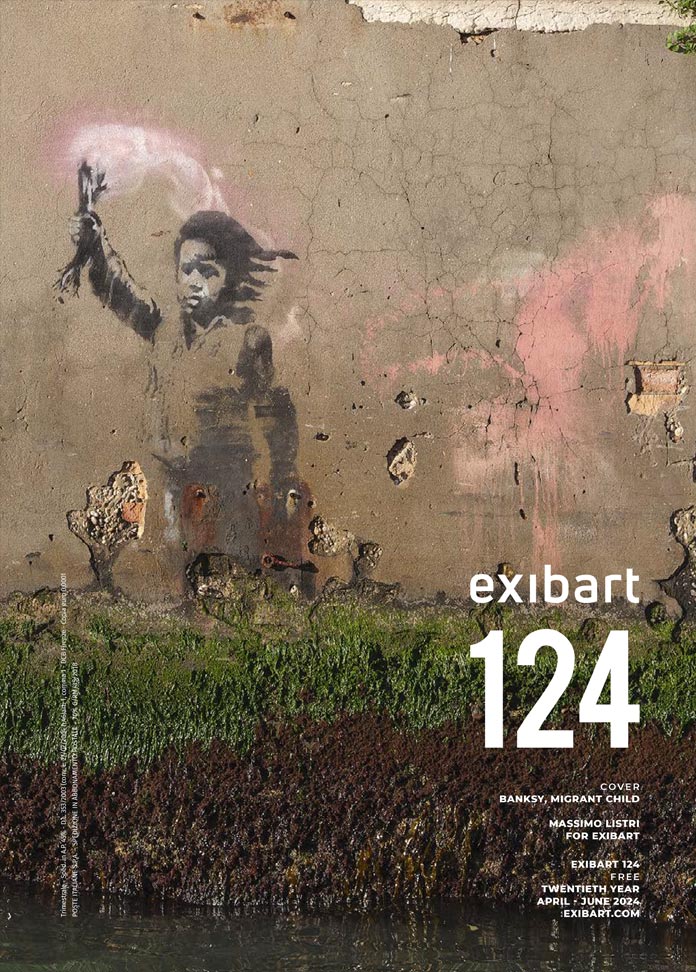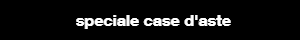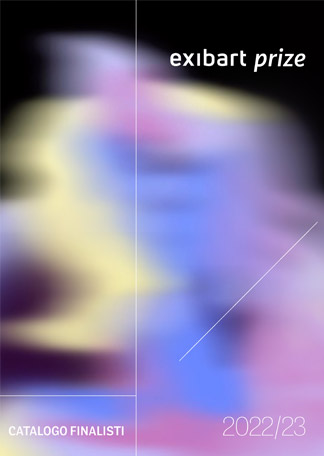Create an account
Welcome! Register for an account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
-
- container colonna1
- Categorie
- #iorestoacasa
- Agenda
- Archeologia
- Architettura
- Arte antica
- Arte contemporanea
- Arte moderna
- Arti performative
- Attualità
- Bandi e concorsi
- Beni culturali
- Cinema
- Contest
- Danza
- Design
- Diritto
- Eventi
- Fiere e manifestazioni
- Film e serie tv
- Formazione
- Fotografia
- Libri ed editoria
- Mercato
- MIC Ministero della Cultura
- Moda
- Musei
- Musica
- Opening
- Personaggi
- Politica e opinioni
- Street Art
- Teatro
- Viaggi
- Categorie
- container colonna2
- container colonna1
15
maggio 2017
Senza illusione le occasioni svaniscono
Personaggi
Incontro con Pietro Fortuna tra le sue opere al MACRO Testaccio. Ecco le sue parole sulla mostra “S.I.L.O.S” e su 40 anni di idee: pacate ma decise, ordinate in un flusso denso
A cura di Pietro Gaglianò, “S.I.L.O.S” è il titolo della mostra dedicata a Pietro Fortuna negli spazi di MACRO Testaccio, in collaborazione con la galleria Montoro12. Un progetto per ricostruire, in maniera non cronologica, il percorso dell’artista (Padova, 1950) oggi residente tra Roma e Bruxelles. Una mostra che vuole porsi come un “osservatorio” per mettere in luce processualità e idee, condizioni preminenti rispetto all’esito “formale” dell’opera, secondo Fortuna. Un senso del fare come prassi e come teoria, come rivendicazione di autonomia, come possibilità e diritto dell’arte a essere improduttiva. E a pochi giorni dall’otium e negotium con cui Christine Macel ha inaugurato la sua Biennale, Fortuna ci dice la sua sul tema. E anche sull’arte, e il “mondo” dell’arte.
In che senso questa mostra è un’antologica?
«È un’antologia di idee e non una raccolta cronologica delle mie opere; non è importante che quarant’anni di attività siano tracciati cronologicamente attribuendo alle opere il carico di certificare questo percorso. Il vero intento è di testimoniare un fare attraverso idee, procedure e teorie che non solo hanno determinato quel passato, ma che sono l’inalienabile condizione per produrre ancora oggi delle opere e di anticipare, in forma di profezia e non di previsione, quelle che seguiranno. Ecco come si spiega che il ciclo che ho intitolato S.I.L.O.S. è stato realizzato appositamente per questo evento impegnandomi a offrire le ragioni più remote di un fare che non si esaurisce nel fatto, le stesse ragioni che mi portano a diffidare di ogni forma di compimento. Come ci ricorda Jacques Rancière, Platone è chiarissimo quando imputa a chi imita la realtà non tanto la responsabilità di produrre immagini false, quanto che il principio mimetico di fatto prevede che si compiano due lavori insieme. Un fare che è comune a ogni lavoro e un fare che allo stesso tempo produce pensiero. L’imitazione è quindi una tecnica e non una finzione, una tecnica funzionale alla produzione di un pensiero, un modo di fabbricare il visibile, dando al principio privato del lavoro una scena pubblica. Quindi non solo con queste parole si decreta che il pensiero è una tecnica ma che l’arte non può prescindere dalla condizione di produrre un pensiero. Eppure è credenza comune nei circoli dell’arte che le opere non debbano essere fino in fondo debitrici di un pensiero e che possano in ogni istante contraddirlo, abbandonarlo. Mentre è il pensiero a tradire l’opera, a prendersi gioco delle sue soluzioni. La maggior parte degli artisti, per non far torto al senso comune, preferisce spostare l’irragionevolezza dalla parte del fare non considerando che al pensiero è dato pensare l’impensabile mentre la forma non è mai di per sé l’avventura di un pensiero. Ecco perché confido nelle risorse di un pensiero che abbia la capacità di non esaurirsi nella consapevolezza del limite, che sappia uscire da quell’impianto ottico che è alla radice del pensiero dell’Occidente e che impone uno sguardo prospettico e finalistico, a cui si può aderire solo attraverso la speranza di un compimento».
Spesso tu parli di arte come bene
«Sì, ma non è un bene da riscattare. È quell’ebbene di cui spesso ho parlato che ci dissuade da ogni negoziazione con il reale. È semplicemente un modo di attardarsi, guardare intorno a sé senza essere né sedotti, né spinti a volere. Con S.I.L.O.S, l’acronimo di Senza Illusione Le Occasioni Svaniscono, intendo anche dire che ad esempio l’illusione di andare verso il reale o di esserne raggiunti, che è un punto fermo della nostra visione umanistica, ci porta a credere che questo doppio movimento rappresenti la scena, il teatro delle nostre occasioni. L’occasione non ci appartiene, non appartiene al vivente, alla natura; per un albero crescere non è un’occasione. Quindi preferisco pensare a un’arte che si esprime attraverso una maniera felice, soddisfatta di sé, che sa ascoltare il rumore di fondo del reale. Il reale non ha bisogno di nessuna occasione per mostrarsi, non fa nulla per presentarsi, esibendo nell’attualità della sua indifferenza soltanto la propria nudità; si dà pur non offrendosi, come Gloria dell’inessenziale, irriducibile a ogni misura, distanza, revocando quel dispositivo dualistico che la ragione utilizza per allestire le nostre visioni elaborando quel mondo che possiamo raccontare in quanto è il prodotto di un pensiero finalistico. Un pensiero della fine, un pensiero escatologico che si consuma nell’attesa e nella promessa di una redenzione. Nel mio lavoro esprimo, invece, la volontà di abbandonare le pretese di un umanesimo che vede l’uomo come portatore di un’interrogazione privilegiata che lo obbliga a fornire di volta in volta le risposte necessarie attraverso la produzione di modelli e dogmi che attingono a quel lungo processo di individuazione da cui abbiamo tratto le figure di soggetto, oggetto, corpo, sostanza, e soprattutto coscienza».
Dove “agisci”, dunque?
«Mi interessa esplorare quel territorio che attiva certi psichismi, stati di pre-coscienza, al limite di quel difficile intrattenimento con gli oggetti del reale prima che diventino cose. Non a caso latini, che hanno avuto più tempo di noi per pensare, distinguevano le cose dagli oggetti, intendendo con res, che ha la stessa radice di retorica, ciò di cui si può parlare da obiectum, ovvero ciò di cui non si può parlare. Oggi, che abbiamo molto meno tempo per pensare, perché totalmente occupati a dimenticare sia il sapere che il dubbio, viviamo in un presente diffuso dove le cose sono percepite come offerta alle nostre intenzioni, lì pronte al consumo… basta solo attenersi alle istruzioni per l’uso. E l’arte, facendo sfoggio delle sue attitudini di dismissione da ogni mediazione teorica, non è da meno anzi vanta di trattare le proprie opere come oggetti di design. Basta ascoltare il commento degli artisti, fiscale, attento ai dettagli, conforme alla peggiore letteratura didattica. Insomma è il peggior modo di disfarsi di quella norma mai scritta che fa dell’arte una segreta tensione tra sentire e sapere».
Hai avuto dei maestri?
«Sì, ma i miei maestri non li ho trovati nell’arte, perché nell’arte non c’è nulla da imparare, così come nessuno impara a respirare. Poi in genere s’impara a fare qualcosa sempre a partire da cosa non si deve fare e alla fine ogni insegnamento si risolve nel prepararti a essere prudente. Diciamo che devo la mia prudenza alla lettura: Meister Eckhart, Cusano, Beckett, Severino, Ruyer, James…
Anche dal cinema ho avuto molto sebbene mi abbia stimolato a essere meno prudente sino al punto di desiderare di fare un film».
Ti piacerebbe lavorare nel cinema?
«Sì. A parte che ho avuto già occasione di buttar giù qualche sceneggiatura, ma sto lavorando per fare il mio primo film. Forse perché inconsciamente preferisco il buio delle sale, dove per vedere qualcosa almeno rischi di inciampare mentre nelle gallerie stai lì sotto i fari come un fesso con un bicchiere in mano…».
“Opera Paese”, il centro culturale da te fondato nel 1996 a Roma e rimasto attivo fino al 2004, metteva in dialogo diverse discipline filosofia, arte, musica…
«La musica contemporanea innanzi tutto, che è stata da sempre una mia passione; abbiamo collaborato e lavorato con tantissimi autori come Giya Kancheli, Brian Eno o Philip Glass. E con filosofi come Carlo Sini, Rocco Ronchi. Chiaramente, per un fatto affettivo, abbiamo commissionato delle opere ad amici artisti, Kounellis, Pistoletto, Jan Fabre, e molti altri, suscitando tra coloro che si sono sentiti esclusi reazioni poco piacevoli».
A proposito di depressione culturale, come ti pare Roma ultimamente? Sarebbe possibile oggi un’esperienza come “Opera Paese?
«Nonostante tutto sono ottimista, che non è così lontano dall’essere imprudente…Proprio pochi giorni fa ho proposto alla direttrice della GNAM di ripercorrere la storia di “Opera Paese”. Non vorrebbe essere una celebrazione semmai uno stimolo per i giovani. Oggi per motivi biografici non rifarei la stessa esperienza, tra l’altro vivo da un anno e mezzo in un altro Paese. Roma è una città che ha costruito dei grandi miti, non che mancassero delle vere eccellenze ma diciamo che per coprire una mediocrità diffusa, e la mediocrità è sempre scandalosa quindi dovrebbe semmai indurre al ritegno, si è accontentata di parlare in nome di.
Pensi che comunque sarebbe possibile fare qualcosa di simile oggi?
«Secondo me sì. Ad esempio con alcuni amici stiamo preparando in rete un lavoro molto interessante utilizzando la mia biblioteca tematica. L’idea, alla maniera di Warburg, è quella di spostare dei libri da uno scaffale all’altro per ridisegnare nuovi percorsi di senso».
Perché Bruxelles?
«Bruxelles è una città che ho scelto perché facilita il mio lavoro sotto ogni aspetto. Roma è troppo complicata, la posta in gioco è modesta e non giustifica che impegni a vuoto le mie energie. Spaccia per pigrizia quelli che sono in realtà dei limiti oggettivi che non hanno nulla a che fare con un costume, con la forma di un attivismo snob che si riserva in ogni momento di tirare fuori la carta vincente. In realtà, il gioco è sospeso, la tradizione fatica a salvare il presente. Gli artisti non viaggiano e chi l’ha fatto per qualche ragione, ha poi difficoltà a trovare le ragioni sufficienti per tornare. Ciò è molto triste, ma è così. Pensare che la propria città sia di per sé un traguardo è solo un paradosso, arrivare primi senza aver mai veramente gareggiato, questo dovrebbe far riflettere tutti, tanto gli atleti che i loro gregari, è una corsa da fermi. Fino agli anni ‘60 abbiamo dominato l’arte mondiale, e dunque qualcosa è pur successo, ma per presunzione da una parte e per carenza dall’altra adesso dobbiamo patire che tutto il mondo parla la nostra arte mentre noi siamo gli ultimi a farla parlare. E quando vai all’estero con 40 anni di lavoro, centinaia di mostre, devi ricominciare; nessuno ti riconosce quello che hai fatto perché quel poco che raccontano le nostre biografie è soltanto il magro bottino conseguito da una condizione provinciale di conflittualità che infine antepone strategie e magheggi alla qualità, al senso che chiunque pretende di riscattare dalle nostre opere. Quindi la scelta di Bruxelles è una scelta tecnica. Una scelta tecnica, anche questa…che non tocca le ragioni del cuore».
Mario Finazzi