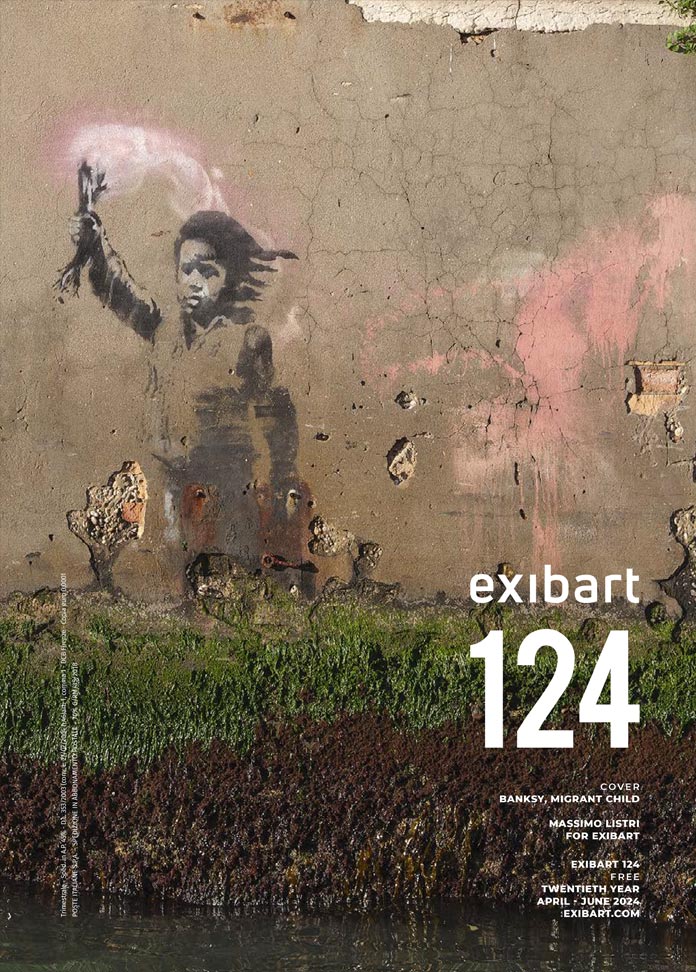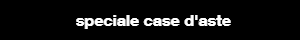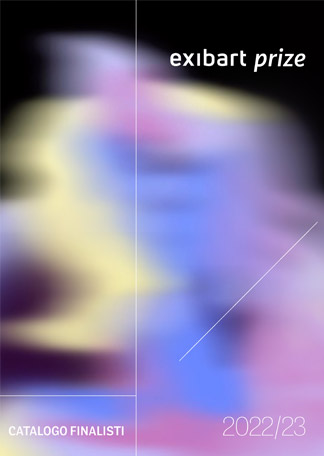Create an account
Welcome! Register for an account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
-
- container colonna1
- Categorie
- #iorestoacasa
- Agenda
- Archeologia
- Architettura
- Arte antica
- Arte contemporanea
- Arte moderna
- Arti performative
- Attualità
- Bandi e concorsi
- Beni culturali
- Cinema
- Contest
- Danza
- Design
- Diritto
- Eventi
- Fiere e manifestazioni
- Film e serie tv
- Formazione
- Fotografia
- Libri ed editoria
- Mercato
- MIC Ministero della Cultura
- Moda
- Musei
- Musica
- Opening
- Personaggi
- Politica e opinioni
- Street Art
- Teatro
- Viaggi
- Categorie
- container colonna2
- container colonna1
Nel 1512, Giulio II Della Rovere, il tenace papa guerriero committente di Michelangelo e Raffaello, acquisì per la sua collezione di opere antiche una statua la cui provenienza era e resta tutt’oggi ignota, e che dalla fine del secolo precedente adornava il cortile di Palazzo Maffei nel Rione Pigna. Scambiata allora per una Cleopatra morente a causa del bracciale in forma di aspide avvolto attorno al braccio sinistro, si capisce bene come questo papa risoluto, che aveva voluto prendere il nome del grande dittatore romano e che per difendere la sua autorità temporale era disposto a guidare un esercito oltre che a dettare il (fin troppo!) trasparente programma iconografico della Stanza di Eliodoro, volesse inserire la figura della disgraziata regina egiziana tra le bellezze che adornavano il suo Belvedere.
Invece, nel XVIII secolo, Ennio Quirino Visconti la interpretò correttamente come un’Arianna, la principessa cretese figlia di Minosse e di Pasifae. La statua è una copia romana derivante, come una sua sorella agli Uffizi, da un archetipo ricondotto a maestranze pergamene del II a.C.
Arianna, che aveva aiutato Teseo nella terribile impresa di uccidere lo spaventoso Minotauro ed era poi fuggita con l’eroe, giace reclinata su un letto di rocce dove si è lasciata andare esausta e affranta, dopo aver vagato disperata alla ricerca dell’ingrato, che l’ha abbandonata completamente sola sull’isola di Nasso. La statua ricorda le figure di Pablo Picasso, con le gambe e le braccia tonde e tornite, quasi giganti, e le linee di contorno sicure ed essenziali che chiudono i volumi dei solidi semplici che la compongono.
La storia di Arianna è raccontata da Ovidio nelle Metamorfosi, ma la versione operistica che ne diede Richard Strauss su libretto di Hugo von Hofmannsthal, rappresentata nel 1912 con il titolo Ariadne auf Naxos, dà al mito una chiave che rivela ancora più chiaramente l’eterna attualità della fenomenologia dell’abbandono e dell’amore.
Dunque, la ragazza dorme il sonno della disperazione; al suo risveglio, incontra Dioniso e, dopo i primi equivoci (lei lo confonde con l’amante precedente, poi lo prende per la morte da lei invocata), i due si piacciono, si innamorano, e restano insieme. A questo punto dell’opera straussiana, i commedianti che hanno seguito il dramma come un coro allegro e scanzonato chiosano: Ella si abbandona alla morte – non c’è più – sparita – immersa nel mistero della trasformazione – e rinasce – vive di nuovo tra le braccia di lui! – Egli così diventa un dio. Nel mondo per che mai ci eterniamo se non per questa sorte?
Secondo il mito narrato da Ovidio, in onore di lei Dioniso getta in cielo un diadema di stelle: la Corona Boreale che nel nostro emisfero possiamo osservare nelle notti di primavera ed estate.
La metafora è trasparente: addormentata, come la nostra facoltà di amare quando ci sentiamo abbandonati e traditi, Arianna si risveglia, ma fatica a riconoscere chi ha davanti, perché la sua vista è stata deformata dal passato: nel nuovo che le si fa incontro crede di vedere l’immagine cui suo malgrado è affezionata, o che la condiziona. Vede la morte stessa: per tornare a vivere non dobbiamo forse uccidere, coraggiosamente, una parte di noi? Tuttavia questa morte è una fase di trasformazione, dopo la quale si diventa più autenticamente se stessi, e si può ancora amare. E chi ci ha restituiti alla vita e all’amore ci appare certamente un dio, capace di fare di noi una gloriosa creatura degna di una costellazione tra gli astri.
Mariasole Garacci
(Foto di Mariasole Garacci)